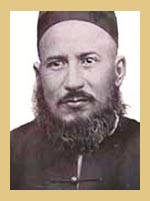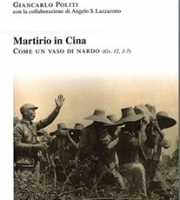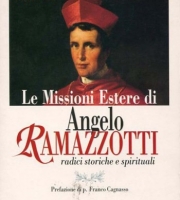Comunità missionaria
Il PIME è una Comunità di vita apostolica, così come è previsto dal codice di diritto canonico. La comunità del PIME è formata da sacerdoti e laici che desiderano donare la propria vita per l'espansione del messaggio di Cristo e della Chiesa. Per questo motivo si sentono uniti dalla stessa vocazione e da un vincolo di appartenenza. Far parte del PIME significa vivere il suo carisma personalmente e assumendosi anche la responsabilità di tutti i confratelli che hanno fatto la stessa scelta.
Naturalmente è una comunione nella carità e nella diversità. Questo per evitare l'antica tendenza a considerare i confratelli solo oggetti pazienti e deboli mezzi, pensiero che può emergere tutte quelle volte che si desidera governare senza realmente servire. Gesù mandò 72 apostoli a due a due, ma non li considerava dei numeri.
Certamente essere membro di una comunità, umana o religiosa che sia, non significa accontentarsi di farsi servire per essere poi sciolti dai comuni impegni. Si rischierebbe di fare delle scelte anche sbagliate magari a scapito di altri. Si dice infatti che l'individualismo porti solo all'incuria, alla bruttezza, alla scortesia, allo spreco, formando solo 'invalidi' che hanno bisogno di essere accompagnati, salvati e quindi costretti a delegare la propria volontà a coloro che sono in grado di attuare validi progetti.
D’altra parte, però, se in una società o comunità l’autorità non rispetta o trascura i suoi membri è evidente che non si potrà mai essere vera fratellanza. A questo riguardo, nel limite del possibile, ciascuno deve poter esprimere il proprio dissenso quando altri, amici o non, non ricevono carità e egual trattamento, anche qualora personalmente si venga trattati bene. A volte si tende a pensare che la preoccupazione per/di un singolo individuo sia futile in confronto ai problemi della comunità allargata geograficamente o più ampia come quella internazionale. Se però riflettiamo più a fondo comprendiamo che se si ignorassero gli individui la situazione non migliorerebbe di tanto. Buona parte dei problemi derivano dal pensare che l'individuo non esista se non in quanto membro, attivo o passivo che sia, di un gruppo. Gli si chiede una sorta di oblio di sé. Perdere se stesso nella comunità che lo circonda, nella cosiddetta ‘tribù’. L'unità nella carità e nella diversità è invece un aiuto fondante di nuovi rapporti, che sorregge l’idea che ognuno è qualcosa di più del gruppo a cui appartiene.
Certo, si tratta di concetti ancora disattesi. Si vorrebbe sostituire questa diversa unità l'orgoglio di appartenere al proprio gruppo, alla propria istituzione. Una incoerenza forse. Ogni gruppo, infatti, prova lo stesso orgoglio che provano gli altri gruppi. Ciascuno rivendica le stesse cose e non riconosce di possedere, quale tratto comune, l'umanità; non ammette che una persona sia qualcosa di più o di meno del gruppo di cui fa parte; dimentica la propria contingenza storica; non riconosce le diversità al proprio interno e non usa i propri carismi. In questi casi, allora, essere rispettosi e attenti membri di una comunità elimina una possibile ‘falsa’ appartenenza, e, quindi diventa una rivendicazione alla comune umanità. In fondo, per noi, di non essere pecorelle numerate, ma discepoli liberamente in cammino guidati dalla fede in Cristo e da una reciproca e forte fiducia.